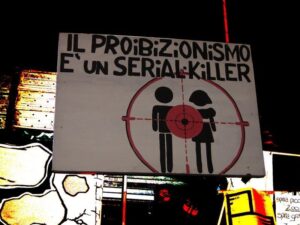
Proponiamo questa traduzione integrale come uno spunto di lettura e visione d’insieme per un approfondimento della concezione e del retroterra culturale sull’antiproibizionismo agli albori dell’ultimo decennio del XX secolo. Qui la sociologa canadese, testimone di un approccio di inchiesta e valutazione dell’impatto e delle politiche politiche – proibizioniste, repressive/regressive e/o sperimentali verso una depenalizzazione non solo delle droghe – si sofferma sulle nuances strategiche del pensiero abolizionista, cogliendone i tratti comuni con antirazzismo e transfemminismo da una parte, e l’immaginazione di prospettive emancipatorie o meno di autorganizzazione e/o politiche comunitarie di “refund”e “abolitionism”. Uno stimolo a inquadrare la tematica e la riflessione in un momento in cui le politiche confinatorie, segregazioniste e stigmatizzanti si sono acuite, in particolare a partire dal riassestamento post-pandemico dei mercati globali, per giungere alla recrudescenza guerrafondaia e sanzionatoria “dell’Occidente” sotto gli occhi di tutt3. (10/03/2025)
The Journal of Drug Issues 20(4), 533-542, 1990
OLTRE L’ANTIPROIBIZIONISMO
Negli anni ’80, abbiamo assistito alla rinascita del movimento a favore dell’abrogazione delle leggi sulla droga che avevano segnato gli anni’ 70 e all’emergere dell ‘”antiproibizionismo”. I fautori sono stati eminentemente uniti nella loro lotta contro qualsiasi forma di criminalizzazione delle sostanze, sulle concezioni riguardo il loro uso e il loro commercio, ma non condividono gli stessi punti di vista su ciò che va oltre l’abrogazione del divieto.
Mentre alcuni vedono la depenalizzazione ‘de jure’ come loro obiettivo finale e unico, altri pensano che la loro preoccupazione per la moralità e la salute pubblica, così come le esigenze di una reale libertà di scelta, richiedano che la produzione e la circolazione delle droghe appena liberate abbiano una garanzia di regolamentazione. Questi sono i fautori della politica di legalizzazione. In entrambi i gruppi, c’è chi vorrebbe procedere per fasi e chi preferisce una soluzione più globale che comprenda tutte le sostanze contemporaneamente. Tra questi ultimi, alcuni favoriscono l’estensione dell’antiproibizionismo ad ambiti diversi dai farmaci.
Mentre l’antiproibizionismo è relativamente chiaro e semplice da capire – sostiene la rimozione dalle leggi penali di tutti i riferimenti alle droghe ora illegali – i suoi sostenitori differiscono per quanto riguarda le sue implicazioni future. Al fine di comprendere meglio i diversi risvolti che possono avere da una politica abolizionista, appare utile esaminare le diverse opinioni all’interno del movimento antiproibizionista contemporaneo.
ANTIPROIBIZIONISMO.
Gli anni ’80 hanno visto una rinascita e un radicamento del movimento di depenalizzazione del 1970. Venti anni fa, molti paesi, in particolare quelli impegnati in inchieste nazionali sull’uso non medico delle droghe, sono stati spinti da importanti settori del pubblico a rivedere le loro leggi sulle droghe in direzione della depenalizzazione. Questo è stato il caso, a varie intensità, di Canada, Gran Bretagna, Paesi Bassi, Francia, Nuova Zelanda e Australia. Alla fine degli anni ’80, vediamo emergere un movimento che chiarisce le questioni politiche e morali già racchiuse nell’idea di depenalizzazione e che, a mio avviso, si colloca su un’agenda più più ampia e coraggiosa.
Ci sono almeno quattro diverse organizzazioni che lavorano nella direzione dell’antiproibizionismo, tutte nate negli ultimi anni:
- CO.R.A., ovvero il Coordinamento Radicale Antiproibizionista, su spinta del dal Partito Radicale italiano;
- il Movimento Europeo per la Normalizzazione delle Politiche sulla Droga fondato alcuni anni fa da giuristi olandesi impegnati nelle commissioni europee sulle politiche penali, che raggruppano psichiatri e giuristi;
- la Drug Policy Foundation, creata negli Stati Uniti nel 1987, che ha ripreso e ampliato notevolmente il lavoro di NORML, l’Organizzazione nazionale per l’abrogazione delle leggi sulla marijuana; e
- la Lega Internazionale Antiproibizionista, creata nel marzo 1989, con il patrocinio congiunto del Partito Radicale e del CO.R.A.
Tutti i membri delle organizzazioni sopra menzionate concordano sul fatto che le attuali leggi sulla droga devono essere abrogate perché si sono dimostrate moralmente, istituzionalmente, umanamente ed economicamente intollerabili. Gli atti del colloquio tenutosi a Bruxelles nell’ottobre 1988 che diede vita alla International League (Roma, marzo 1989) portano un titolo che racchiude l’essenza di quel consenso: “The Cost of Prohibition on Drugs” (Coordinamento Radicale Antiproibizionista, 1988).
Ma l’unanimità di fondo non è stata del tutto raggiunta. Sebbene molte persone ora concordino sull’intollerabilità del divieto delle droghe e si siano impegnate a lavorare per la rimozione dalle leggi penali di tutte le menzioni di sostanze ora criminalizzate, ci sono almeno quattro modi diversi di concepire ciò che dovrebbe accadere una volta avvenuta la depenalizzazione. È sufficiente togliere dal codice penale ogni riferimento alle droghe ormai illegali, come suggeriscono alcuni antiproibizionisti? Siamo convinti che la depenalizzazione “pura e semplice” metterà fine alla guerra alla droga, agli osceni profitti dei cartelli di spacciatori e limiterà, relativamente parlando, i problemi legati all’abuso di droga?
Mentre molti antiproibizionisti odiano vedere qualsiasi forma di regolamentazione statale applicata alle droghe ora illegali, altri sono convinti che la semplice depenalizzazione non sia sufficiente e lascerà un enorme mercato preda dei feroci appetiti delle persone che bramano profitti rapidi senza preoccuparsi della salute e del bene generale. Sostengono che è necessario un processo di legalizzazione e di regolamentazione delle droghe, interne ed esterne, come per qualsiasi sostanza che possa essere venduta e acquistata.
Inoltre, mentre alcuni sostenitori della “sola depenalizzazione” sostengono che sarebbe saggio procedere passo dopo passo, uno o due farmaci alla volta, altri sono convinti che la depenalizzazione immediata sia un imperativo. Lo stesso vale per la legalizzazione: tra i suoi fautori, alcuni vorrebbero procedere per fasi, altri raccomandano la legalizzazione immediata. Non è possibile valutare scientificamente nel dettaglio tutte le conseguenze economiche, sociali, giuridiche e culturali di ciascuno di questi corsi (o di altri), ma possiamo delineare gli scenari pertinenti ad alcuni e il loro impatto.
DEPENALIZZAZIONE “SEMPLICE”.
Esistono molti tipi di depenalizzazione. In primo luogo, c’è la depenalizzazione di fatto, una politica in base alla quale le forze dell’ordine si astengono dall’applicare le leggi esistenti alle persone colpevoli di semplice possesso, che trattano per i propri bisogni o che usano e trattano sostanze che si ritiene siano le meno assuefacenti o letali. La maggior parte dei nostri paesi occidentali pratica la depenalizzazione de facto su larga scala. In Canada, ad esempio, ci sono circa 15.000 tossicodipendenti noti alla polizia, ma solo una manciata di loro viene arrestata ogni anno. Nelle città di Zurigo e Milano, dove assistenti sociali e
antiproibizionisti distribuiscono siringhe pulite ai tossicodipendenti in luoghi pubblici alla presenza di funzionari comunali e forze dell’ordine, si può dire che praticano una politica di depenalizzazione de facto.
La città di Amsterdam ha praticato per molti anni una politica di depenalizzazione di fatto – prima con cannabis, poi con altre droghe.
Tuttavia, ciò che gli antiproibizionisti richiedono non è la depenalizzazione de facto, ma la depenalizzazione de jure: l’abrogazione formale dalle convenzioni internazionali e dai codici penali nazionali che menzionano tutte le sostanze psicotrope ora illegali. Secondo gli antiproibizionisti, la depenalizzazione di fatto si presta a eccessiva discrezionalità giudiziaria, ingiustizia e arbitrarietà.
È possibile una depenalizzazione così semplice de jure senza una qualche forma di regolamentazione? Cosa avremmo ottenuto se i farmaci fossero stati tolti dalle leggi penali, ma non fossero stati soggetti al controllo del prezzo e della qualità? Condivido il punto di vista di LeDain su questo: solo quelle sostanze che si possono coltivare o produrre
per se stessi si presterebbero a una semplice depenalizzazione de jure (Commission of Inquiry into the Non-medical Use of Drugs 1972 e 1973).
In Canada, ma più in generale in Nord America e nel mondo occidentale, ci sono leggi molto severe che regolano il commercio e la somministrazione di alimenti, bevande e tutti i beni di consumo. I controlli di qualità e prezzo si applicano a tutte le sostanze che possono essere vendute e acquistate. Ovviamente, si possono coltivare verdure nel proprio orto e condividerle con amici e parenti, o persino scambiarne alcune.
Tuttavia, non appena si intende dare in vendita al pubblico, si deve fare affidamento sul controllo della qualità e dei prezzi e sulle agenzie che esercitano tali controlli.
Le sostanze e i prodotti chimici “domestici” che sono facilmente fabbricati in un laboratorio domestico possono sfuggire alle leggi del mercato economico e alla regolamentazione per prezzo e qualità. Ma almeno due tra le maggiormente importanti droghe illegali non possono essere coltivate tanto facilmente nell’emisfero settentrionale. Sono cocaina ed eroina. Pertanto,
la loro accessibilità ai cittadini del Nord America e dell’Europa occidentale richiede l’importazione. Una moltitudine di leggi regolano l’importazione di merci nei nostri paesi e non si vede un modo per sfuggire a questi controlli e regolamenti nel caso delle droghe.
Nonostante questi problemi, la semplice depenalizzazione de jure ha molti vantaggi.
- L’abrogazione nelle convenzioni internazionali e nella legislazione nazionale di tutti i riferimenti alle droghe ora illegali libererebbe considerevolmente il sistema di giustizia penale a ogni livello della struttura: la polizia, i tribunali, le carceri e i servizi di libertà vigilata e condizionale.
- I servizi di trattamento per gli autori di abusi sarebbero semplificati e resi più efficienti. I tossicodipendenti che vogliono abbandonare l’abitudine al consumo ora devono affrontare il doppio rischio della dipendenza e le conseguenze penali dell’abitudine.
- I paesi risparmierebbero enormi quantità di denaro ora speso per i sistemi di giustizia penale inondati di casi di droga.
- I nostri governi sarebbero meno imbarazzati moralmente di quanto lo siano ora, di fronte alle accuse di incoerenza e incoerenza perché due droghe molto legali, alcol e tabacco, sono così dannose quando alcune sostanze proibite non presentano gli stessi rischi per la salute.
Ma la semplice depenalizzazione non porta solo vantaggi. Vediamo.
- Molti osservatori hanno notato che, a seguito della depenalizzazione, l’uso potrebbe aumentare.
- In assenza di controllo di qualità, un maggiore utilizzo potrebbe significare più rischi per la salute e un aumento delle spese sanitarie. Esistono, tuttavia, serie confutazioni di tale tesi (Nadelman 1989).
- In assenza di controllo dei prezzi, la depenalizzazione potrebbe essere accompagnata da lotte inter-gruppo, concorrenza e violenza nel mercato della droga.
La semplice depenalizzazione ‘de jure’ senza regolamentazione dell’accesso ai farmaci non è una soluzione realistica. Naturalmente, la storia è molto diversa per le persone che vivono in paesi in cui la maggior parte o la totalità delle sostanze desiderate sono accessibili attraverso la propria coltivazione o industria; in tali circostanze, la semplice depenalizzazione è una soluzione interessante ed economica.
Tra i fautori della semplice depenalizzazione de jure ci sono quelli che sostengono la politica “una droga alla volta” e quelli che optano per la “depenalizzazione totale” di tutte le droghe. Mentre ci sono serie obiezioni alla prima alternativa (legalizzazione graduale), abbiamo visto la logicità di una politica di depenalizzazione immediata di tutte le sostanze che possono essere prodotte a livello domestico.
LEGALIZZAZIONE.
Nessuno tra i fautori della legalizzazione contesta il fatto che l’opzione di legalizzazione comporti controlli su qualità, prezzo, metodo di fabbricazione, coltivazione, distribuzione, importazione ed esportazione. Naturalmente, tutti i sostenitori della legalizzazione concordano sul fatto che dovremmo lavorare per porre fine al divieto di droghe illecite. Oltre a ciò, i sostenitori della legalizzazione differiscono ampiamente nei modelli che sostengono. Ci sono due punti di divisione principali: acredini tra coloro che raccomandano una politica graduale rispetto a coloro che adottano una visione di legalizzazione totale, e in secondo luogo, tra coloro che favoriscono un modello in cui i consumatori potrebbero acquistare direttamente i farmaci che desiderano rispetto a coloro che raccomandano che molte delle sostanze popolari siano disponibili solo attraverso le prescrizioni dei medici.
LEGALIZZAZIONE STEP-BY_STEP
Molti sostenitori della legalizzazione vorrebbero procedere a passi, che coinvolgano una o due sostanze. Come, ad esempio, la posizione di Lester Grinspoon e James B. Bakalar (vedi in questo volume). La “tassa sulla nocività” di Grinspoon-Bakalar verrebbe attuata in fasi. La fase uno comporterebbe alcool, tabacco e cannabis: i primi due perché sono già legali, e il terzo perché “è probabilmente la droga meno pericolosa usata per il piacere” (vedi pagina 601 di questo volume). La pubblicità sarebbe vietata. La vendita verrebbe effettuata tramite punti vendita appositamente autorizzati a un prezzo determinato da una commissione.
Il modello di Grinspoon e Bakalar si basa sull’elasticità della domanda (in particolare nel caso dell’alcol, gli studi dimostrano che quando il prezzo è abbastanza alto, ci sono meno bevitori problematici e problemi di alcol). L’inelasticità della domanda, secondo Grinspoon e Bakalar (vedi pagina 602 in questo volume), è maggiore nel caso del tabacco perché la nicotina “è una delle sostanze che crea più dipendenza”. Tuttavia, il consumo di tabacco diminuisce con prezzi più alti, ma questi ultimi contribuiscono principalmente a scoraggiare i potenziali fumatori, in modo che a lungo termine, prezzi più alti ridurranno il consumo totale. Contro questo modello, molti antiproibizionisti e pro-legalizzazione ritengono che, per quanto vorrebbero procedere con cautela, la politica graduale sposterebbe e concentrerebbe il commercio illegale, la violenza e lo sfruttamento sul mercato delle droghe ancora illegali, rendendo il traffico di cocaina ed eroina più redditizio e l’uso più pericoloso.
CONTROLLO MEDICO SU ALCUNE DROGHE, PRINCIPALMENTE EROINA E COCAINA.
Altri sostenitori della legalizzazione, per lo più medici, sostengono la fine del divieto perché ritengono che tutte le sostanze dovrebbero essere disponibili per scopi medici e che il divieto di prescrizione di eroina o morfina sia stato molto dannoso per la medicina e per molti pazienti (del Gatto 1988). Questa è in una certa misura la posizione delle persone che hanno trovato veri usi medici della marijuana e che vogliono che quella droga sia disponibile non solo per scopi ricreativi ma anche per curare alcune malattie. Pur riconoscendo le inutili restrizioni imposte alla medicina dal proibizionismo, molti antiproibizionisti non sosterrebbero una politica che trasferirebbe il controllo di tutti i farmaci illegali a medici e farmacisti.
Al contrario, molti antiproibizionisti ritengono già che le professioni mediche e farmaceutiche abbiano troppo controllo sulle sostanze psicotrope e che le professioni sanitarie abbiano talvolta usato il loro potere in modo imprudente, essendo colpevoli di sovra-prescrizione tra le altre cose. Tuttavia, alcuni potrebbero voler limitare l’uso dei farmaci reputati più avvincenti alle persone che sono già dipendenti e che sarebbero quindi fornite attraverso la prescrizione e la supervisione medica (il modello del metadone ma con i farmaci “reali”). Altri sono a favore di una politica di libertà di scelta. Li chiamo i fautori della legalizzazione totale.
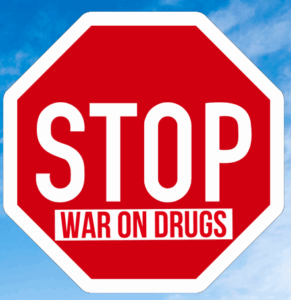
LEGALIZZAZIONE TOTALE.
C’è chi propone la legalizzazione totale di tutte le droghe sotto un modello simile a quello che prevale per l’alcol: i negozi controllati dallo stato venderebbero la sostanza sotto etichette che indicano con precisione la sua potenza e il suo contenuto. La vendita ai minori, così come la vendita a persone già in visibile stato di ebbrezza, sarebbe vietata. La maggior parte dei sostenitori della legalizzazione totale sarebbe a favore di un aumento di prezzi e per tasse elevate, basandosi come fa Grinspoon sull’elasticità della domanda e sperando di frenarne l’uso e mantenerlo entro limiti accettabili (Bertrand 1973 e 1988; Nadelman 1989; Reisinger 1988).
I benefici economici della legalizzazione totale sono evidenti. La legalizzazione ha lo stesso impatto della depenalizzazione sul sistema di giustizia penale, riducendo il numero di persone processate e i costi sociali della loro criminalizzazione. Il controllo del prezzo e della qualità di molte nuove sostanze comporterà necessariamente un notevole aumento del numero di persone impiegate nelle amministrazioni alimentari e farmaceutiche, nonché nel settore della distribuzione. Significherebbe anche notevoli entrate per lo stato attraverso la tassazione.
I rischi derivati dall’abuso sotto la legalizzazione totale sarebbero più considerevoli che sotto la depenalizzazione e si estenderebbero a più sostanze che in tutti gli altri modelli.
Tuttavia, raramente gli autori sono unanimi nel valutare questi rischi. Nadelman (1989), ad esempio, conclude una seria revisione di quanto comprovato con queste parole di cautela: è cioè impossibile prevedere se la legalizzazione porterebbe o meno a livelli molto maggiori di abuso di droghe. Le lezioni che si possono trarre da altre società sono miste. L’esperienza della Cina con gli spacciatori di oppio britannici del XIX secolo, quando milioni di persone sarebbero diventate dipendenti dalla droga, offre uno scenario peggiorativo. La devastazione di molte tribù di nativi americani da parte dell’alcol ne presenta un’altra. Dall’altra, la depenalizzazione della marijuana da parte di 11 stati negli Stati Uniti durante la metà degli anni ’70 non sembra aver portato ad aumenti del consumo di marijuana. Nei Paesi Bassi, che sono andati ancora oltre nella depenalizzazione della cannabis durante gli anni ’70, il consumo è effettivamente diminuito in modo significativo; nel 1976 il 3% dei quindicenni e sedicenni e il 10% dei diciassettenni e diciottenni usavano occasionalmente la cannabis; nel 1985, le percentuali erano scese rispettivamente al 2% e al 6%. La politica è riuscita, come il governo intendeva, “nel rendere noioso l’uso di droghe”. Infine, l’America della fine del XIX secolo è un esempio di una società in cui non c’erano quasi leggi sulle droghe o addirittura regolamenti sulle droghe, ma i livelli di consumo di droghe erano quelli che sono oggi. L’abuso di droghe era considerato un problema relativamente serio, ma il sistema di giustizia penale non era considerato parte della soluzione.
Quasi tutti i fautori del sistema di legalizzazione totale sostengono alcune misure restrittive. Ad esempio, non solo vieterebbero tutte le promozioni e limiterebbero le ore in cui i farmaci sono disponibili, ma alcuni limiterebbero la quantità venduta agli utenti in un’occasione (Caballero 1989). In generale, tutti ammettono che le droghe non sono merce ordinaria e che dovrebbero essere tenuti sotto il controllo dello stato, che dovrebbe avere il monopolio in materia (Caballero 1989: 127). Le conseguenze morali del modello di legalizzazione totale sono notevoli.
Tanti autori hanno descritto gli effetti moralmente dannosi della classificazione inetta che le convenzioni sulle droghe hanno stabilito e il fallimento del proibizionismo e dei suoi costi morali tanti che bisogna essere convinti che queste politiche abbiano contribuito al cinismo morale di generazioni di cittadini e al mancato rispetto della legge (Apap 1988). Restituendo ai cittadini il controllo sui loro corpi attraverso la propria libertà di scelta, lo stato ricreerebbe una condizione in cui prevale la responsabilità individuale e le scelte incaute diventano più difficili.
Sono a favore di un modello che preveda la legalizzazione di tutte le droghe piuttosto che un processo graduale e l’accesso diretto dei consumatori alle sostanze di loro scelta piuttosto che il controllo da parte dei medici sul consumo individuale. Tuttavia, concordo con entusiasmo con tutte le persone pro-legalizzazione che sostengono il divieto di incentivazione di tutte le droghe, tasse elevate, prezzi abbastanza alti e monopolio statale.
VERSO UNA POSIZIONE MINIMALISTA E ABOLIZIONISTA NELLE QUESTIONI DI POLITICA PENALE.
Ritengo che la lotta contro il proibizionismo in materia di stupefacenti stia portando a una posizione più realistica e saggia rispetto a ciò che può essere raggiunto a un livello più ampio attraverso il controllo penale. Può essere, nell’attuale crisi mondiale la cui precipitazione è acuita dal proibizionismo, che l’urgenza sia tale da poterci autoregolare sulle questioni relative alle droghe. Tuttavia, suggerisco che potremmo da più parti far luce sulla questione e smorzare in parte la compulsività che tocca la questione delle droghe affrontando altri problemi dei nostri codici penali che derivano dalla stessa concezione pregiudiziale del ruolo del diritto penale. Sto parlando della necessità di abolire tutti i crimini senza vittime come l’aborto, la prostituzione e la sollecitazione, la pornografia e il dissenso ideologico e politico.
Andiamo avanti. Come possiamo tollerare che i nostri codici penali stabiliscano sanzioni molto gravi, tra cui l’incarcerazione, per semplici furti o taccheggi in paesi in cui dal quindici al venti per cento della popolazione vive sotto il livello di povertà reale? Come possiamo sostenere il fatto che la maggior parte delle disposizioni dei nostri codici penali ha a che fare con la proprietà privata e la necessità di rispettare i beni dei datori di lavoro e delle aziende che non solo non contribuiscono al benessere generale, ma spesso sono direttamente responsabili del nostro malessere per negligenza criminale a causa delle condizioni che lasciano prevalere sul lavoro o per l’inquinamento di cui sono direttamente responsabili? Quali sono questi valori che i nostri codici penali ci impongono di rispettare? Che tipo di atteggiamenti staremmo sanzionando con i mezzi più coercitivi a disposizione dello Stato?
A mio avviso, non sono solo le leggi contro la droga che dovrebbero essere abrogate, non sono solo i crimini senza vittime che devono essere eliminati dai nostri codici penali. È anche il sistema di giustizia penale che deve essere sostituito da accordi civili come la conciliazione, le riparazioni e gli accordi. La persona lesa e il suo aggressore non vedrebbero il loro conflitto risolto dallo stato, impedendo loro di diventare passivi e irresponsabili, ma lavorerebbero insieme per risolvere il loro conflitto. Non sono il solo a pensare che cittadini e intellettuali responsabili debbano fare del loro meglio per far abolire il sistema di giustizia penale, per quanto utopistico possa sembrare. Sedici anni fa, Mathiesen scrisse il suo Politics of Abolition (1974). Hulsman seguì poco dopo con una conferenza a Lione, in Francia (1977) sul paradigma abolizionista e in seguito formulò a lungo la propria prospettiva abolizionista (1981) con la collaborazione di Jacqueline Bernat de Celis nel 1982.
Baratta (1983), Bianchi e Swaaningen (1986) e Blad (1987) riconoscono che non dovremmo lavorare per riformare il sistema di giustizia penale, ma lavorare per abolirlo.
A mio avviso, la proibizione della droga non è che uno dei sintomi della terribile malattia di cui soffre il sistema di giustizia penale: ecco una struttura potente che aggrava le iniquità e che può solo riprodursi e aumentare sé stessa come avviene con tutte le burocrazie – un sistema che è al servizio della polizia e dell’apparato giuridico invece di servire i cittadini che sperimentano dolorosi conflitti tra loro o con lo Stato. Cominciamo con l’abrogazione delle leggi sulla droga, ma non fermiamoci qui.
BIBLIOGRAFIA:
Apap,G. 1988 “Mettere in motra i tossicodipendenti si qualifica come ideologia?” The Cost of Prohibition on Drugs, Radical Party and CO.RA. (eds.) 210-218, Roma: Coordinamento Radicale Antiproibizionista.
Baratta, A. 1983 “Sur la criminologie critique et sa fonction dans la politique criminelle. Conference prononcée au Congres de la Société internationale de criminologie.” Vienna, Settembre.
Bertrand, MA. 1973 “Ulteriori conclusioni e raccomandazioni.” In Commission of Inquiry into the Non-Medical Use of Drugs, Final Report. Ottawa: Informazioni Canada.
Bertrand, MA. 1988 “L’immoralità del proibizionismo.” In The Cost of Prohibition on Drugs Radical Party and CO.R.A. (eds.) 170-179, Rome: Coordinamento Radicale Antiproibizionista.
Bianchi, H. e R. Van Swaaningen (a cura di) 1986 “Abolitionism. Toward a non-repressive approach to crime Amsterdam” University Press 2016.
Blad, J.R., H. van Mostrigt e N.A. UILDRIKS 1987 “The criminal justice system as a social problem: An abolitionist perspective.”
Rotterdam: Erasmus Universiteit. Caballero, F. 1989 “Droit de la drogue.” Paris: Dalloz. Commission of Inquiry into the Non-Medical Use of Drugs| 1972 “Cannabis”.
Ottawa: Informazioni Canada. “Commissione d’inchiesta sull’uso non medico di droghe” “Relazione finale” 1973.
Ottawa: Informazioni Canada. Del Gatto, L. 1988 “Le catene del proibizionismo e la libertà del medico”. In “The Cost of Prohibition on Drugs”, Radical Party and CO.RA. (eds) 136-144,
Roma: Coordinamento Radicale Antiproibizionista, Hulsman,L. “Le paradigme “criminologique” abolitionniste et la recherche sur la categoric de crime.” “Conference aux tables rondes du C.N.R.S. sur connaissance et fonctionnement de la justice penale: Perspectives sociologiques et criminologiques.”
Lione, gennaio. Hulsman,L. 1981 “Une perspective abolitionniste du systeme de justice penale et un schema d’approche des situations problematiques.” “In Dangeros et justice penale7-16, C. Debuyst (ed.), Collection Deviance et Societe, Geneve: Medecine et Hygiene”.
Hulsman, L. e J. Bernat de Celis 1982 Peines perdues, le systeme penalen question.
Parigi: Le Centurion. Mathiesen, T. 1974 The politics of abolition. . I-III).
Londra: Martin Robinson. Nadelman, EA 1989 “Proibizione della droga negli Stati Uniti: costi, conseguenze e alternative.” Science 245: 240-246.
Partito Radicale e CO.R.A. (a cura di) 1988 “The Cost of Prohibition on Drugs.” Roma: Coordinamento Radicale Antiproibizionista. Reisinger, M. 1988 “Premesse per la legalizzazione”. In “The Cost of Prohibition on Drugs”, Radical Party and CO.RA. (eds.)” 159-162, Roma: Coordinamento Radicale Antiproibizionista.